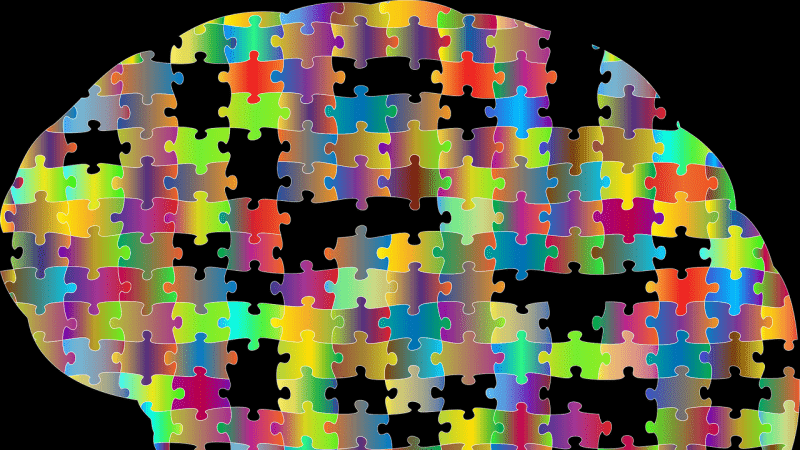Vissuti ed emozioni di un umano qualsiasi: uno psicoterapeuta
Si suggerisce l’ascolto del brano “Closer to the heart“ (Rush, 1977) durante la lettura.
Ecco un altro aspetto del nostro lavoro di cui forse non si parla abbastanza: il terapeuta può essere un umano, con una vita normale, noiosa e a volte perfino problematica. Una vita non perfetta. Con delle normali zone d’ombra o aspetti personali non risolti. Come chiunque, in pratica. Di solito, mentendo ed illudendoci, ci dicono e a volte ci insegnano che dovremmo essere controllati, risoluti, imperturbabili. Dei “mini Budda”. Nessuno dice che, in realtà, non solo questo non è possibile ma per le terapie non serve nemmeno.
Non possiamo essere dei robot perché in effetti siamo fatti di carne ossa, con un cuore che batte e una mente che pensa, perfino con degli occhi che piangono. L’avreste mai detto? Se ci pensiamo, nella rappresentazione comune, ad esempio se il paziente parla di cose dure o crude, il terapeuta non dovrebbe mai commuoversi, figuriamoci piangere poi mentre guarda il finale di “Gran Torino” o il training montage di “Rocky II” (Quando Adriana dice: “Vinci, vinci”). Cavolo, e allora come la mettiamo con tutte quelle volte in cui ci commuoviamo nel sentire le storie struggenti dei pazienti? Ne parla approfonditamente Virginia Failoni in questo articolo Quando è il terapeuta a piangere.
Oppure si pensa comunemente che il terapeuta non debba avere insicurezze, paure o fobie, che non può provare rabbia, odio o tristezza e che deve sempre cavarsela in ogni situazione. Com’è possibile questo? Su dai, siamo terapeuti e sappiamo che le emozioni esistono! Quello che a volte manca è l’attrezzo per leggerle: l’autoriflessività. Ma se invece raggiriamo l’alessitimia capiamo bene che è proprio l’autenticità di un terapeuta sufficientemente “umano” e fisiologicamente a contatto con le proprie aree di vulnerabilità, che favorisce una maggiore vicinanza ed una buona riuscita della terapia, soprattutto con i pazienti cosiddetti “difficili” (ad esempio con nucleo borderline o dell’area psicotica). Infatti le emozioni dolorose non riconosciute ed eventualmente non espresse con chiarezza dal terapeuta, se attive in seduta, vengono comunque percepite grazie alla naturale trasmissione emotiva e somatica veicolata dai neuroni specchio, e attraverso una serie di segnali non verbali. Questo può, in alcuni casi, favorire l’attivazione di sottili cicli interpersonali disadattivi, inficiando il successo terapeutico (Liotti & Farina, 2011; Dimaggio, Popolo, Ottavi, Salvatore, 2019). Inoltre, in qualità di esseri umani, anche noi terapeuti abbiamo i nostri stati mentali interni e le nostre strategie di coping per fronteggiarli. Chi oscilla nella ruminazione, chi nel perfezionismo, chi nel ritiro. Se da un lato sappiamo (o almeno dovremmo sapere) che i coping ci fanno restare a lavoro fino alle 10.00 di sera, rischiando il burnout o di gestire male una relazione terapeutica, non sempre riusciamo a regolarli. Alcune strategie di coping, per loro natura, rafforzano le idee nucleari collegate allo schema disfunzionale maladattivo (Dimaggio, Popolo, Ottavi, Salvatore, 2019), ma per altri versi ci aiutano a raggiungere grandi risultati, ad esempio in termini di performance. Infatti a partire da un wish di apprezzamento potremmo avere una rappresentazione di noi stessi di scarso valore a fronte di un altro umiliante/critico.
Nel tentativo di gestire le emozioni che ne deriverebbero, come la vergogna, giusto per citarne una, le strategie di coping si attivano in modo automatico. Tra di esse il perfezionismo, il raggiungimento di standard elevati, il controllo relazionale, possono essere di aiuto, illudendoci che in questo modo l’altro non avrà modo di essere critico. Ma è davvero un modo funzionale per gestire la rappresentazione di sé schema correlata? (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013). L’aspetto importante resta collegato alla consapevolezza e alla regolazione di essi. Come abbiamo accennato non è sempre semplice perché per loro natura schemi e coping si attivano in modo automatico e procedurale (Dimaggio, Popolo, Ottavi, Salvatore, 2019). Eppure la riflessione su questi nostri aspetti ci permette di capire quanto è difficile raggirare l’evitamento per un paziente evitante oppure gestire i pensieri sospettosi per un paranoide. D’altronde, se è vero che ognuno di noi ha una sua organizzazione di personalità, dei tratti che rientrano nelle categorie diagnostiche dei disturbi di personalità del DSM-5, allora perché dovremmo noi terapeuti essere sovraumani? Perché reprimerli o inibirli? Faremmo fatica e sarebbe più patologico cercare di nasconderli che riconoscerli, integrarli e regolarli.
Infine, un altro aspetto critico: nell’era dei social i pazienti sanno chi siamo ancor prima di venire in studio. Conoscono il nostro viso, la nostra età e la nostra formazione. L’accesso ai numeri di telefono è così semplice che basta salvarlo in rubrica per poter sbirciare l’immagine WhatsApp. Quindi non dovrei sentirmi libera di utilizzare la foto buffa con mia nipote e il suo cerchietto con l’unicorno? Oppure quella con il mio partner? O ancor meno quella in cui mi scateno in discoteca? O davanti a una moltitudine di bottiglie di vino a cena con gli amici? Condividere su Facebook le mie idee politiche, religiose o musicali? E magari ho anche faticato tanto per scrollarmi da dosso quel perfezionismo e workaholism lavorativo per godermi il tempo libero, divertendomi. E anche lo sport, se mi piace fare danze caraibiche piuttosto che combattimento dovrei farmene un cruccio? Secondo l’immaginario comune andrebbe meglio lo yoga o il pilates per uno psicologo. Zumba, già siamo al limite, ma solo per le terapeute donne. Per i maschi è concesso il circolo degli scacchi e senza esagerare, quello del nuoto.
Se ci sentiamo liberi di essere quello che siamo non tremiamo più quando un paziente ci chiede: “Ma lei ha mai fumato uno spinello?” Oppure: “Dott. ma lei la terapia l’ha fatta?”. Ora come ora non mi faccio più problemi se vado a ballare e trovo il paziente del mercoledì delle 11.00 e non mi faccio più crucci se mi lascio andare ad un karaoke e guarda caso il proprietario del bar è un mio cliente. Quanta fatica mi è costata per arrivare a fare shopping nell’atelier della paziente del giovedì alle 20.00? Oppure se mi diverto e faccio casino a un concerto rock, ovvio, senza sforare gli articoli 28 e 38 del codice deontologico! Se c’è una cosa che abbiamo imparato, però, è che permettere agli altri di intravedere gli aspetti più umani di noi stessi a volte può essere una svolta perfino nella terapia. Ad esempio, recentemente, un paziente mi disse: “Dottore ha l’aria stanca tutto bene?”. Anni fa mi sarei irrigidito e avrei risposto frettolosamente che andava tutto bene cambiando subito discorso. Questa volta invece mi sono quasi rilassato, gli ho risposto che era vero, che ero stanco per via di un trasloco che pareva non finire più e che mi stava stressando tantissimo. Il paziente mi ha ascoltato con interesse dicendomi che mi capiva benissimo dato che lui nella sua vita aveva già fatto 4-5 traslochi. Ci siamo poi confrontati per qualche minuto su questo argomento condividendo aneddoti e impressioni. C’è stata intimità, empatia non eravamo più dottore e paziente, ma due persone in rispecchiamento reciproco di stati interni e mutue debolezze in cui il paziente può avventurarsi in un mondo relazionale inesplorato ma in un contesto sicuro (Hill, 2017).
Se, per certi versi siamo fortunati perché riusciamo a comprendere un minimo di più la mente umana e conosciamo alcuni meccanismi psicologici, nonostante questo restiamo esseri umani. E, come tali, abbiamo le nostre criticità. Ma se grazie al nostro lavoro personale (ne abbiamo parlato nell’articolo L’intreccio tra la supervisione e la psicoterapia personale), abbiamo faticosamente abbandonato i coping, abbiamo superato paura del giudizio o di critica, e abbiamo anche visto quanto è stata dura, allora sappiamo quello che stiamo chiedendo ai nostri pazienti. Potremmo perfino diventare dei modeling sufficientemente incoraggianti per l’altro. Sappiamo che è possibile lavorare sullo schema, sulle emozioni, gestire le normali ricadute, esplorare parti sane di sé o crearne di nuove se necessario. Senza saperlo il nostro modo di pensare, di stare in relazione, di lavorare con gli assetti interni viene implicitamente appreso dai pazienti e questo spesso è utile nella regolazione emotiva. Ad esempio, un paziente spaventato o disregolato può essere aiutato da un nostro stato interno regolato, ma non solo da esso. Quando i pazienti osservano i nostri comportamenti buffi, i nostri errori in diretta e “apprendono” come possono essere anche loro così, funzionare bene anche se non perfetti, ad esempio. Tale processo favorisce l’integrazione: parti di sé e dell’altro, che possono sembrare dissonanti, in realtà fanno parte dell’individuo nella sua totalità. Agli occhi dei pazienti restiamo terapeuti presenti, accoglienti e validanti anche se rovesciamo una tazza di thè mentre compiliamo la fattura, oppure diamo due appuntamenti alla stessa ora.
Non siamo sempre noi?
Oppure tutte le volte che una mia paziente cita luoghi, negozi famosi della mia città che io non conosco e mi prende in giro per questo, o quando la rinite cronica è in fase acuta e durante la seduta consumo 3 pacchi di fazzoletti cercandoli in giro come un tossicomane zombie, non siamo sempre quel terapeuta lì? Insomma il paradosso è che un terapeuta sanamente “scompensato” appare integro agli occhi del paziente. Il terapeuta è un essere umano con le sue parti sane e le sue fragilità, ma rimane comunque stabile nella mente del paziente, una persona che risponde in modo adeguato ai suoi bisogni (Meares, 2014). Rimaniamo integri anche se a volte ci capita di…….?
E qui ognuno di noi può pensare a un proprio comportamento all’apparenza “scompensato”. Con sincerità! Ma se proprio questa proposta vi attanaglia e non vi sentite liberi vi ricordiamo che, almeno in questo momento mentre state leggendo, nessuno vi guarda nella mente!
Scritto da: Vito Lupo, Virginia Valentino
Bibliografia:
Dimaggio G., Montano A., Popolo R., Salvatore G. (2013). Terapia metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Dimaggio, G., Ottavi, P., Popolo, R., Salvatore, G. (2019). Corpo, immaginazione e cambiamento. Terapia metacognitiva interpersonale. Milano: Raffaello Cortina.
Hill, D. (2017). Teoria della regolazione affettiva. Un modello clinico. Milano: Raffaello Cortina.
Liotti G., Farina B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Milano: Raffaello Cortina.
Meares R. (2014). Un modello dissociativo del disturbo borderline di personalità. Milano: Raffaello Cortina.